L’interpretazione per la retta applicazione del diritto

Benedetto XVI all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 del Tribunale della Rota Romana, nel discorso tenuto il 21 gennaio, ha trattato un argomento spesso non preso sufficientemente in considerazione, ma assolutamente essenziale nella concreta vita e applicazione del diritto, ovvero il tema dell’interpretazione della legge canonica. L’interpretazione è infatti lo snodo ineliminabile attraverso cui il diritto astrattamente posto dal legislatore per il bene comune trova concreta applicazione nei casi specifici. A ben vedere infatti nella realtà non esiste un diritto puro, astratto che trova applicazione di per se stesso, ma al contrario nelle diverse fattispecie viene applicato sempre il diritto che hic et nunc l’opera ermeneutica del giudice arriva ad individuare come il più appropriato nel singolo caso venuto al suo esame.
Da un punto di vista logico, il procedimento seguito ogni volta che si applica una qualsiasi norma giuridica è simile allo schema di un sillogismo: esiste un ordinamento fatto di norme generali e astratte e una singola fattiscecie concreta. Qualora il fatto concreto venga ricondotto nell’ambito della norma generale si producono gli effetti giuridici previsti dalla norma stessa nel caso di specie. Il termine tecnico usato in questo caso è quello di sussunzione: come la premessa minore viene fatta rientrare nella premessa maggiore per arrivare ad una conseguenza, così la fattispecie concreta viene riassunta nella norma astratta, per determinare conseguentemente su quel caso gli effetti voluti dalla norma stessa.
Tuttavia se in termini logici la questione è così inquadrata correttamente, da un punto di vista pratico sorgono non poche difficoltà. Infatti determinare se una data norma (e quindi la produzione in concreto degli effetti giuridici da essa previsti) debba trovare applicazione in concreto è sempre e solo frutto di un’interpretazione del giudice che deve leggere la disposizione, dargli un senso e verificare se nell’estensione del suo ambito di operatività rientri anche il caso sottoposto alla sua decisione. Ne discende che una stessa identica norma può paradossalmente trovare o meno applicazione, o avere comunque applicazioni diverse, a seconda della diversa interpretazione che ad essa venga eventualmente data dai Tribunali.
Si tratta ineludibilmente di un punto fondamentale che, se non sufficientemente chiarito, porta a metttere in crisi il ruolo stesso del diritto e la sua funzione ordinatrice per la società ed il bene comune. Anche il migliore ordinamento infatti, se interpretato in maniera sbagliata, può portare ad effetti nefasti. Disapplicare una norma o viceversa esigerne un’osservanza ultronea è sempre e solo conseguenza di un’opera interpretativa.
Interpretare la legge significa darle un senso, valutarne la portata, deciderne la rilevanza per il caso concreto: non si tratta mai di un’operazione ermeneutica fine a stessa, come sarebbe quella di un testo letterario, quanto piuttosto di un’attività eminentemente pratica. L’interpretazione della legge porta infatti come conseguenza il prodursi di effetti giuridici.
La determinazione se una data norma (e quindi i suoi effetti) trovino spazio hic et nunc è una operazione eminentemente soggettiva e come tale sfugge ad una predeterminazione assoluta, lasciata inevitabilmente alla prudente valutazione del giudice.
Ecco perchè per evitare arbitri è lo stesso ordinamento a porre da se stesso, per quanto possibile, trattandosi comunque di criteri logici, le regole su come debba essere condotta la fase ermeneutica, per evitare che il diritto e la certezza che esso deve garantire per l’ordinato vivere sociale possa essere di fatto lasciato al sentire del singolo giudice.
Se questo è vero per qualsiasi ordinamento giuridico, lo è ancor più per l’ordinamento canonico ove, come ha ricordato il Papa, è evidente “l’incidenza che esso ha per la salus animarum del Popolo di Dio”.
Anche l’ordinamento canonico pone dunque i criteri logici mediante i quali l’intero sistema normativo deve essere interpretato. La relativa previsione è contenuta al can. 17 CIC, secondo cui le leggi sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole, considerato nel testo e contesto, e quando ancora si mostrassero ambigue, si deve ricorere a luoghi paralleli, al fine e alle circostanze della legge e all’intendimento del legislatore. Seguendo queste indicazioni il giudice è chiamato a compiere l’interpretazione canonica, diretta a dare significato concreto alla norma che altrimenti rimane un mero enunciato letterario, per una sua adeguata applicazione. Il canone sitato fa riferimento ad un concorso di criteri ben noti alla teoria generale del diritto: l’interpretazione letterale (senso proprio delle parole), quella contestuale e sistematica (parole lette nel testo e contesto, alla luce dei principi genarali e della altre norme poste dallo stesso ordinamento), quella analogica (riferimento a casi simili o materie analoghe) e quella teleologica (fine voluto dal legislatore o ratio legis).
Ma, come è evidente, trattandosi di un’operazione che resta soggettiva, nonostante questi criteri peraltro inevitabilmente generici, l’interpretazione rimane un’attività elastica in cui si corre il rischio di cortocircuito dell’intero sistema giuridico.
Storicamente, ci sono state due opposte impostazioni nell’affrontare la questione: per la scuola del positivismo giuridico il giudice non è che la “bocca della legge”, come insegna Montesquieu, la sua opera interpretatrice non avrebbe alcun margine di soggettività ed il sillogismo giuridico sarebbe identico a quello matematico. Il preconcetto ideologico che vizia questa impostazione giacobina è evidente nel fatto stesso che la realtà non può essere imbrigliata in termini completi all’interno delle maglie normative dell’ordinamento giuridico. Anche il noto brocardo latino per cui in claris non fit interpretatio, presuppone comunque una valutazione soggettiva di cosa e fino a che punto sia chiaro.
L’impostazione opposta è quella del giudice creatore del diritto: l’ordinamento pone dei principi, delle indicazioni di massima ed è poi l’interprete che, partendo da quei principi, determina egli stesso la norma per il caso concreto. In questo senso sono spiegati da una parte della dottrina gli ordinamenti anglossassoni di common low in cui la proncunica giudiziaria determina un precedente vincolante, in quanto essa stessa crea la norma per il caso concreto a prescindere da una precedente formulazione ordinamentale generale e astratta. Anche in questo caso, l’eccessivo soggettivismo di una simile posizione ne vizia l’impostazione concettuale, in quanto renderebbe quasi inutile l’opera del legislatore.
Tra queste opposte letture si pone in concreto l’opera ermenuetica del giudice che determina il diritto nel caso di specie, ma non lo crea.
Nel suo discorso alla Rota Benedetto XVI dà una serie di indicazioni precise su come compiere concretamente l’interpretazione della legge canonica, evidenziando molto bene quali possono essere i rischi a cui si va incontro quando si perdono di vista gli elementi fondamentali a cui la legge della Chiesa si ispira.
Il Papa riconosce con molta chiarezza come l’interpretazione sia “un aspetto primario del ministero giudiziale” in quanto non si tratta di una mera questione di “assonanza semantica, considerato che il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso, e che la lex agendi non può che rispecchiare la lex credendi”.
Da qui derivano appunto una serie di indicazioni operative. La prima: “l’ermeneutica del diritto canonico è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa” e da questo consegue che “l’interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa”. Chiarisce ancora Benedetto XVI che “non si tratta di una mera circostanza esterna, ambientale” ma rappresenta piuttosto “un richiamo allo stesso humus della legge canonica e delle realtà da essa regolate”.
Anche nell’attività interpretativa del singolo operatore giuridico non può mancare mai il sentire cum Ecclesia che assume in ambito giuridico un significato peculiare, ma pur sempre presente “a motivo dei fondamenti dottrinali, presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa”.
Sentire cum Ecclesia significa che al singolo giudice non è consentito operare scelte arbitrarie o in contrasto con il patrimonio, non solo giuridico, ma prima ancora dottrinale e di fede che la Chiesa custodisce. Significa anche che ogni decisione canonica non è mai espressione di un singolo tribunale (e ancor meno “contro” qualcuno) ma è sempre decisione della Chiesa, per il bene dei fedeli.
Ancora: è vero che nell’ambito canonico ha un ruolo fondamentale l’equità, intesa come giustizia del caso concreto che tende ad adattare le norme, oltre la loro lettera, alla sostanza e peculiarità del caso specifico (cfr. can. 19). Un tale criterio era ben noto anche al diritto classico, in cui già si era capito come summum ius, summa iniuria. Nella legge della Chiesa ciò comporta delle implicazioni ancor più rilevanti in quanto una formalistica interpretazione della legge che non tenesse conto della specificità di ogni singolo irripetibile caso potrebbe addirittura rivelarsi contraria alla salus animarum, supremo criterio a cui tende il diritto canonico e a cui inevitabilmente deve uniformarsi anche la sua interpretazione (cfr. can. 1752). Tuttavia anche l’opportunità di giungere ad un’applicazione equitativa della legge prevista dal Codice non è comunque tale da trasformare l’ermeneutica compiuta dal giudice in attività creativa del diritto. Una ricerca smodata della norma giusta per il caso concreto svincolata dalle norme positive rischia di cadere nello stesso pregiudizio ideologico positivista, sebbene in senso opposto. “Questa impostazione – ribadisce infatti il Papa – non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l’opera interpretativa umana assurge a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico”.
Si arriverebbe così a poter addirittura prescindere da un diritto oggettivo da cercare, esponendo ogni decisione giudiziaria al pericolo dell’arbitrarietà e quindi dell’abuso. Come sarebbero garantiti i diritti dei christifideles nella Chiesa se un qualsiasi giudice potesse “adattare dinamicamente” la disposizione di legge “a qualunque soluzione, anche opposta alla sua lettera”? La stessa ermeneutica legale verrebbe ad essere snaturata, “in balìa di considerazioni che pretendono di essere teologiche o pastorali”. Come Benedetto XVI già aveva avuto modo di affermare in un suo precedente discorso alla Rota, non può esistere un diritto contrapposto alla pastorale: piuttosto anche le norme giuridiche vanno viste come uno strumento pastorale per la vita della Chiesa ed il bene dei fedeli.
Il Papa ribadisce quindi un concetto ritenuto fondamentale e più volte sottolineato in passato: non ci può essere un’interpretazione autentica del diritto senza giustizia. “Il vero diritto – afferma in termini inequivocabili il Santo Padre – è inseparabile dalla giustizia. Il principio vale ovviamente anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore”.
Se la sussunzione del caso concreto nella norma astratta al fine del prodursi degli effetti giuridici può essere assimilata ad un sillogismo, ciò che lega la premessa maggiore alla premessa minore che l’interprete deve cogliere per l’applicazione corretta della legge è la giustizia. Il diritto è applicato rettamente dal giudice quando la specifica norma in considerazione sia posta per quel caso dall’ordinamento, secondo una sua valutazione soggettiva ma non arbitraria, che ha come criterio ispiratore la giustizia, intesa non solo riduttivamente come somma delle norme giuridiche, quanto piuttosto come coerenza tra ius e bonum.
Solo così – conclude il Papa – si conferma che “anche nell’ermeneutica della legge l’autentico orizzonte è quello della verità giuridica da amare, da cercare e da servire”.
© Riproduzione riservata – www.iuscanonicum.it

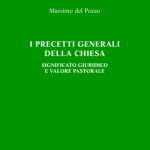






![ecclesiaspeculumiustitiae[1]](/wp-content/uploads/2016/10/ecclesiaspeculumiustitiae1-150x150.jpg)